Aggredito il 13 marzo del '75 da Avanguardia Operaia, morirà il 29 aprile dopo un'orribile agonia.
ll processo per l'omicidio del giovane missino milanese si concluderà solo nel '90
“Hazet 36, fascista dove sei? Hazet 36, fascista dove sei? Hazet36, fascista dove sei?”
Uno slogan, quello di Avanguardia Operaia, che fa gelare il sangue anche a trentotto anni di distanza. Cinque parole che,ripetute ossessivamente, restano il sinonimo di una condanna a morte.
Milano, Marzo ‘75. Sergio Ramelli sta tornando a casa. Fino a qualche mese prima studiava all’Istituto tecnico Molinari. Sezione V J. È bravo a scuola, Sergio. Diligente ed appassionato. Di matematica e di chimica, così come di politica. È di destra, Ramelli. “Fascista” come lo si può essere quando ancora ci si siede tutti i giorni sui banchi, in classe. È un militante del “Fronte della Gioventù”, l’organizzazione giovanile del Msi. L’amore per la politica e l’essere così diligente, firmano la sua condanna a morte. Sì, capita anche questo nella Milano degli anni di piombo. Capita che un bravo ragazzo scriva un tema contro le Brigate Rosse. Capita poi che il collettivo di Avanguardia Operaia “intercetti” misteriosamente quel compito in classe. Ed il gioco è fatto. Basta niente per diventare il bersaglio dei “compagni” di turno. Sputi, insulti, minacce. Tutto nei corridoi di scuola. Tutto sotto gli occhi indifferenti di professori che simpatizzano per i ragazzi di sinistra. A difendere Sergio per aver scritto sulle facciate di un foglio protocollo che i brigatisti rossi non sono eroi, ma assassini (che hanno ammazzato due militanti del Msi a Padova, un anno prima), non si schiera nessuno. Dalla parte di Ramelli ci sono solo i “suoi” camerati del Fronte della Gioventù. Ma questo non basta.
Non ha nemmeno vent’anni, Sergio Ramelli, quando un gruppo di universitari comunisti, tutti più grandi di lui, lo aggredisce sotto casa. Ha cambiato scuola, Sergio. Dopo tutto quello che ha passato al Molinari, i suoi genitori lo hanno iscritto ad un istituto privato, che frequenta il pomeriggio. Per aiutare sua mamma va a fare la spesa vicino casa. Usa il “Ciao”, il motorino –usato- che gli hanno comprato i suoi. Dopo le commissioni, torna a casa puntualissimo, all’una meno dieci, per il pranzo. Il 13 marzo non fa eccezione. Ad aspettarlo, davanti al cancello, sono in cinque. Cinque contro uno. Sergio non ha alcuna possibilità di difendersi. Lo massacrano a colpi di Hazet 36. Una chiave inglese che è lunga 45 centimetri e pesa quasi tre chili e mezzo. Riesce ad essere letale proprio come un colpo di pistola, ma è molto più facile da reperire. Per trovarla basta andare dal ferramenta e costa poco. È perfetta per spaccare il cranio di un ragazzo che non può reagire in alcun modo. Un colpo, due, tre. E ancora, senza fermarsi. Sergio grida, cerca di coprirsi il volto con le mani. Ma non basta. Cade a terra.
Marco Costa, uno degli esponenti di AO, ricorda l’aggressione per filo e per segno. La racconta così, nel 1987, al processo. La sua lucidità è disarmante. “Ramelli capisce, si protegge la testa con le mani. Ha il volto scoperto e posso colpirlo li, al viso. Ma temo di sfregiarlo, di spezzargli i denti. Gli tiro giù le mani e lo colpisco al capo con la chiave inglese. Lui non è stordito, si mette a correre . Si trova il motorino fra i piedi ed inciampa. Io cado con lui. Lo colpisco un’altra volta. Non so dove: al corpo, alle gambe. Non so. Una signora urla ‘Basta, lasciatelo stare! Così lo ammazzate!’ Scappo, e dovevo essere l’ultimo a scappare”.
L’altro killer, Giuseppe Ferrari Bravo ha un ricordo altrettanto nitido: “Aspettammo dieci minuti, e mi parvero un’esistenza. Guardavo una vetrina , ma non dicevo nulla. Ricordo il ragazzo che arriva e parcheggia il motorino. Marco mi dice ‘Eccolo!’, oppure mi dà una gomitata. Ricordo le grida: ‘Basta, basta!’. Dura tutto pochissimo… Avevo la chiave inglese in mano e la nascosi sotto il cappotto. Fu così breve che ebbi la sensazione di non aver portato a termine il mio compito. Non mi resi affatto conto di ciò che era accaduto”.
Quando sua madre arriva, tenendo per mano Simona, la più piccola della famiglia, Sergio ha già perso conoscenza. Il suo “Ciao” è a terra. Intorno a lui c’è un capannello di gente. Mamma Anita si getta su di lui. Respira. È ancora vivo. Sul marciapiede c’è un lago di sangue e frammenti di materia cerebrale. È uno spettacolo agghiacciante. L’agonia di Sergio dura 46 giorni. Anita racconta quell’interminabile mese e mezzo al processo, con un dolore misto ad una dignità sconfinata: “Non dimenticherò mai, per tutta la vita, quando lo portarono all’ospedale. Gli amici di Sergio non lo potevano venire a trovare perché il Policlinico era proprio davanti alla Statale, e i rossi erano sempre la davanti. Tennero anche loro un presidio: non erano in tanti, ma erano li apposta per vedere le facce di quelli che salivano da lui. Sergio, d’altronde, non poteva essere visto da nessuno. (…) Il dottore mi spiegò subito che, purtroppo, essendo Sergio destro e non mancino, sarebbe andato incontro alla sicura paralisi e al mutismo perché gli avevano colpito i centri nervosi più importanti proprio di quel settore cerebrale. Un giorno incontrai anche l’anestesista e mi dichiarò che non aveva mai visto niente di così spaventoso”.
Sempre Anita Ramelli: “Io andavo in ospedale al pomeriggio, mio marito la mattina. Un giorno entrai nella stanza, aveva gli occhi aperti e mi guardava, ma non riusciva a parlare. Emetteva solo suoni, si indicava con il dito la testa. Ricordo che gli chiesi: ‘Sergio, vuoi dirmi che ti fa male la testa?’ Lui scosse leggermente il capo come a dire di no.”
Per un mese e mezzo Sergio Ramelli combatte disperatamente la sua battaglia con la vita. Le lesioni al cranio, inferte con l’Hazet36 che pesa più di tre chili, però, ce l’hanno vinta. Troppo grave il trauma subito. Sergio muore il 29 aprile, a soli 19 anni. La sua colpa è solo quella di essere “fascista”, il peccato originale che condanna tanti ragazzi in quegli anni maledetti che hanno il colore del piombo e delle chiavi inglesi.
Pochi giorni dopo si celebrano i funerali. C’è un mare di gente, tutto il popolo della destra milanese, per dare l’ultimo saluto a quel ragazzo per bene ammazzato con una ferocia inaudita, sotto casa. Solo perché missino. Solo per un tema, in fondo. Eppure, i magistrati dell’Ufficio politico che stanno indagando su chi ha aggredito Ramelli, invece di concentrarsi sull’omicidio, pensano bene di arrestare per “apologia di reato” quattro militanti che, al termine delle esequie, accompagnano il feretro con il saluto romano. Nel frattempo, però, dalle finestre della Facoltà di Medicina che affacciano proprio su Piazzale Gorini, un gruppo di studenti appartenenti ad Avanguardia Operaia sta facendo le foto a tutti i giovani missini che hanno partecipato alla funzione. Quegli scatti verranno ritrovati, anni dopo, nel covo di AO (poi divenuto di “Democrazia Proletaria”) in viale Bligny. A Milano.
Le indagini portate avanti dagli inquirenti nei giorni e nei mesi successivi alla morte di Sergio Ramelli arrivano ad un disarmante nulla di fatto. Tutti sanno come sono andate le cose, ma non ci sono le prove. In ogni caso, l’unica certezza è che i sospetti si concentrano su di un gruppo di universitari della Facoltà di Medicina.
Per conoscere la verità sulla morte di Ramelli si devono aspettare esattamente 10 anni. Il merito è tutto di due magistrati: Maurizio Grigo e Guido Salvini. È grazie ai due giudici istruttori (che nel 1985 stanno indagando sulla “falange” milanese di Prima Linea) che si torna a parlare dell’omicidio del giovane missino. Salvini e Grigo riescono a dimostrare che Autonomia Operaia decide di “condannare a morte” Ramelli appena diventa pubblico il contenuto del suo compito in classe. Roberto Grassi, uno dei capibastone di AO alla Statale di Milano, ex studente del Molinari (l’istituto frequentato da Sergio, prima di cambiare scuola), decide che il gruppetto di universitari, di cui si è autoproclamato capo, è pronto per il suo “battesimo del sangue”. Bisogna andare a“sprangare” un fascista. Questo è l’ordine. Il piano viene preparato da una decina di studenti, quasi tutti della facoltà di Medicina, fra di loro c’è anche una donna (che verrà identificata come Brunella Colombelli). Sotto casa di Sergio arrivano in 4 o 5. Ad aggredirlo, materialmente, sono in due: Giuseppe Ferrari Bravo e Marco Costa.
Il processo per l’omicidio di Ramelli comincia il 14 Settembre del 1987. A difendere la sua famiglia, che si è costituita parte civile, c’è Ignazio La Russa. Sergio è morto da 12 anni.
Ad essere rinviati a giudizio (fra mandanti, preparatori ed esecutori materiali) sono in dieci. Claudio Colosio, Franco Castelli, Giuseppe Ferrari Bravo, Luigi Montinari, Walter Cavallari, Claudio Scazza. Tutti praticanti medici quando inizia il processo e studenti all’epoca dell’aggressione. A questi va aggiunta Brunella Colombelli, diventata nel frattempo ricercatrice.E ancora, Giovanni Di Domenico, al momento dell'arresto consigliere in forza a Democrazia Proletaria a Gorgonzola, nonché Antonio Belpiede, capogruppo del PCI a Cerignola (Foggia) e Marco Costa, che con Ferrari Bravo, oltre ad avere ucciso Ramelli, gestisce anche l'archivio segreto di viale Bligny.
Il 16 maggio 1987 la II Corte d’Assise di Milano assolve Di Domenico per insufficienza di prove. Cavallari viene dichiarato estraneo ai fatti. Tutti gli altri imputati vengono condannati per omicidio preterintenzionale. In sostanza, viene detto, l’idea di partenza non era quella di uccidere Ramelli, ma nel corso dell’aggressione, gli esecutori hanno deciso di correre il rischio che la vittima potesse rimanere uccisa. Marco Costa e Giuseppe Ferrari Bravo vengono condannati rispettivamente a 15 anni e sei mesi di reclusione. Claudio Colosio viene condannato a 15 anni; Antonio Belpiede 13; Brunella Colombelli 12 (per aver indicato al commando di Avanguardia Operaia il luogo e l'ora in cui colpire); Franco Castelli, Claudio Scazza e Luigi Montinari a 11 .
Il 2 marzo 1989 la Corte d’Assise d’Appello di Miano, presieduta da Renato Cavazzoni, riconosce l’attenuante del “concorso anomalo”, che riduce sensibilmente tutte le condanne decise dal Tribunale di primo grado.
Il 22 gennaio 1990 la I sezione della Corte di Cassazione, presieduta da Corrado Carnevale, rigetta i ricorsi della difesa e confermando la sentenza dei giudici d’Appello.
Per arrivare ad una condanna definitiva, sono stati necessari 17 anni. Gli unici ad aver pagato adeguatamente sono stati Costa e Ferrari Bravo, rimasti in galera non per aver massacrato a colpi di chiave inglese un ragazzino di 19 anni, ma per aver continuato nella loro attività terroristica anche negli anni successivi all’aggressione contro il giovane missino.
“È stata tutta una brutta storia/di quelle che ti restano dentro la memoria/dentro la memoria di uno che/la pensa e la pensava come te/come te che sognavi una terra migliore/come te che non volevi l'odio ed il rancore/come te i tuoi sogni spezzati/come te i tuoi progetti rubati/come te la tua morte violenta/come te la tua pur troppo lenta/e la stanza dell'ospedale/non c'è più niente da fare, più niente da fare”.
Enrico Pedenovi: avvocato e missino,
morto per commemorare Sergio Ramelli
Il consigliere provinciale del Msi viene freddato da cinque colpi di pistola a due passi da casa, di prima mattina, mentre si sta recando a lavoro. Quello stesso giorno avrebbe dovuto tenere un discorso in ricordo del giovane ucciso esattamente un anno prima a colpi di chiave inglese da Avanguardia Operaia.
“Vivevamo per essere contro chiunque non la pensasse come noi”.Queste le parole di Marco Donat Cattin, terrorista comunista. Questo il motto dei militanti di Prima Linea e Lotta continua,organizzazione terroristica della sinistra extra parlamentare, responsabili della morte di Enrico Pedenovi. Lui, Enrico, è nato a Pavia il 2 settembre 1926. E quel 29 aprile del 1976 ha 48 anni.Avvocato, ex militante della decima Mas, descritto da tutti come una persona calma e tranquilla. Uno che non perde mai la testa.Vive a Milano Enrico. Ha due figlie: Gianna, 22 anni e Beatrice di 11, ed è sposato con Ida.A chi gli domanda cosa pensi della lotta politica, Pedenovi,risponde così: “la guerra l’ho fatta da ragazzo, e non posso dire certo che sia bella”. Ha deposto le armi, già da tempo Enrico. Ma ha ancora una “colpa”, una “macchia” che non si cancella: è il consigliere provinciale dell’Msi.Quel giorno, il 29 aprile, è lo stesso dell’anniversario dell’omicidio di Ramelli. Non si tratta di una coincidenza, non è un caso. Sì, il povero Sergio, trucidato a colpi di chiavi inglese da un attacco infame, rivendicato da “Avanguardia operaia”, gruppo della sinistra extraparlamentare è morto appena un anno prima.Enrico, quel giorno, deve pronunciare il discorso in onore del giovane missino massacrato il 13 Marzo del ‘75. Sono trascorsi 365 da quando Sergio si è spento (dopo un mese e mezzo d’agonia) in una stanza d’ospedale, ma il vento di tempesta, soprattutto a Milano, soffia ancora, ed è sempre più forte. Non sa da dove iniziare il suo ricordo, Enrico. Di certo non vuole scrivere nulla. Niente di preparato che sappia di “rito” di circostanza.Vorrebbe improvvisare, forse gli sarebbe viene in mente l’applauso vergognoso con cui il consiglio di Milano aveva accolto la notizia della morte del giovane missino. Si,probabilmente vorrebbe iniziare col contestare quell’applauso.Vorrebbe appunto, perché Pedenovi quel giorno non pronuncia un bel niente.In quegli anni se sei “fascista”, ti porti addosso una colpa. Se finisci in tribunale, con un’accusa insensata, è tutto normale. Se muori ammazzato, poi, non c’è da meravigliarsi.Sono tempi difficili quelli. La “guerra civile”, quella degli Anni di piombo è iniziata già da un po’. Ma adesso si è evoluta, qualcosa nel meccanismo che regola gli omicidi politici è cambiato.L’obiettivo non sono più solo i giovani militanti, di destra o di sinistra, com’è stato fino a quel momento. Il nemico da colpire è uno solo: lo Stato. Giudici, avvocati, poliziotti sono le vittime. Brigate Rosse, Lotta Continua e Prima Linea da una parte, i Nar dall’altra, sono i carnefici.Come detto, è trascorso un anno dalla morte di Sergio Ramelli. A Milano si vive sotto una cappa di paura e di tensione. Non passa giorno senza che l'elenco delle aggressioni dell'"antifascismo militante" si allunghi.Il 29 aprile del ‘76, la sinistra extra-parlamentare, appoggiata dal Pci cittadino, è mobilitata con tutte le sue energie, per impedire qualsiasi forma di commemorazione pubblica dell'anniversario. La stessa famiglia di Sergio non riesce a trovare una chiesa in cui far recitare una messa in suo ricordo. Perfino il sacerdote della loro parrocchia, quella di viale Argonne, si rifiuta di celebrare la funzione. Sembra assurdo, ma anche i preti hanno paura, e temono ritorsioni.Arriva così quel mattino maledetto. Tutti già sanno che sarà una giornata dura. Nel pomeriggio è previsto il raduno dei militanti di destra in via Mancini, dove c’è la sede del MSI. Ma loro, i“compagni”, la loro personale “commemorazione” della morte di Ramelli l’hanno già preparata e decisa.Enrico esce di buon’ora. Prima di raggiungere lo studio legale, come al solito, si ferma con la sua utilitaria al distributore di benzina, in via Durante, per acquistare dei quotidiani. Proprio li, tre persone a bordo di una Simca 1000, rubata la notte precedente, non fanno altro che aspettare che Pedenovi sia immerso nella lettura per poi colpire. All’improvviso due degli aggressori iniziano a sparare, contemporaneamente, e con una freddezza disumana. Forse ad Enrico torna in mente quella scritta impressa davanti la sua porta di casa: “10, 100, 1000, Ramelli”.Probabilmente capisce che ce l’avevano con lui. I tre colpiscono l’avvocato. Cinque colpi. Tutti al torace. Quattro lo trapassano da parte a parte, uno rimane incastrato dentro il suo corpo. Soffre Enrico, capisce che la sua ora è arrivata. Eppure lui, il leone ferito,non è ancora morto. Ha la forza di muoversi. Esce dalla macchina. Non si sa come, riesce ad aprire lo sportello. Ha bisogno di aria. Non respira più. E a quel punto è costretto a cedere. L’ emorragia, purtroppo, è inarrestabile. Rimane lì, da solo, in una pozza di sangue. Morirà in ospedale, solo un attimo prima di entrare in sala di rianimazione.Diversamente dagli altri omicidi, l’azione non viene rivendicata da nessuna sigla della sinistra extra-parlamentare. Le indagini della Magistratura, inizialmente, non portano a nessun risultato.Ma Il nome di Enrico Pedenovi, è nell’elenco della lista di proscrizione dal titolo “Pagherete tutto”, che pubblica Lotta Continua su un volantino. Insieme a lui, altri militanti della destra milanese.Quando la notizia della morte di Pedenovi si diffonde, decine di missini, con la rabbia negli occhi, cercano di recarsi sul luogo del delitto per portare un fiore, per esprimere cordoglio alla famiglia. Ma l'intera zona è chiusa e presidiata da un cordone. Non di poliziotti o carabinieri, bensì da almeno seimila compagni che,con i volti coperti e le chiavi inglesi in mano cercano di non far passare i “camerati”. Scoppiano gli scontri, gli inseguimenti e i pestaggi. Chi riesce a forzare il blocco e ad arrivare sul luogo del delitto, non trova nulla, né un fiore, né l'ombra di un membro della forze dell’ordine. Incredibile, ma vero. Qualcuno riuscirà addirittura a sostenere che il delitto abbia una matrice di destra, che ad uccidere Pedenovi siano stati proprio i “suoi” camerati.Stessa assurda strategia utilizzata per il Rogo di Primavalle. Follia allo stato puro.Quello di Enrico è un attacco studiato, con una pianificazione preventiva e dalla spiccata matrice politica. Prima Linea, infatti, si preoccupa subito di garantire la latitanza ai tre killer, che, a tutti o quasi, sono ancora sconosciuti.Ma perché proprio Pedenovi? Innanzi tutto, lui, Enrico, era un“nemico” semplicemente perché esponente del Msi. Ma la risposta definitiva, quella giudiziaria, arriverà solo 8 anni dopo, nel 1984, durante il maxi-processo nei confronti di Prima Linea. Gli esecutori, militanti di Lotta Continua, che aspiravano a diventare futuri terroristi di P.L., scelsero Pedenovi perché era un bersaglio“più facile da colpire rispetto ad altri”.Ma anche perché, come dissero gli imputati: “l'omicidio era legittimato”. Una dichiarazione che Benito Bollati spiega nel suo libro, “Il delitto Pedenovi”, ricordando che, in quegli anni, “era comodo additare i fascisti quali responsabili di tutti i mali, anche quelli di natura sociale ed economica, che non potevano non pesare sui governi, per distrarre l'attenzione della violenza dalle loro persone”.Ecco perché Enrico Galmozzi, uno dei tre killer, disse davanti ai giudici che si sentiva legittimato alla violenza, soprattutto quella contro i "camerati". D’altra parte non c’era corteo organizzato dai comunisti in cui non si urlasse lo slogan “uccidere un fascista non è un reato”.Il 22 ottobre 1984, la Corte d’Assise di Milano condanna all’ergastolo Bruno La Ronga e Giovanni Stefan (latitante) quali esecutori materiali dell’omicidio di Enrico Pedenovi. Enrico Galmozzi dovrà scontare a 27 anni di reclusione in virtù dell’autocritica espressa in dibattimento. Infine, Piero Del Giudice, viene condannato a 28 anni come “concorrente morale nell’omicidio”.Ida Pedenovi, la moglie di Enrico, non vuole parlare di quel giorno. “No, la prego, a casa non venga (riferito a Luca Telese,autore del libro “Cuori Neri”, ndr) io ho già sofferto troppo, e le mie figlie ancora più di me. Non resta nulla da dire. La ringrazio se scriverà qualcosa su mio marito, ma io non ho nulla da dire. Ho due figlie, e un giorno una mi disse: ‘mamma, anche se ti rompi la testa contro il muro, papà non tornerà più’”.A queste parole non si può aggiungere altro. E, intanto, su quel maledetto marciapiede, dell’avvocato missino rimaneva solo una macchia di sangue sull'asfalto, per la quale nessuno aveva il coraggio di mostrare pietà, in un grigio squallore, figlio della paura e dell'inciviltà, simboli di quegli anni impossibili.Forse è proprio destino che gli uomini di coraggio muoiano così, uccisi dai vili.

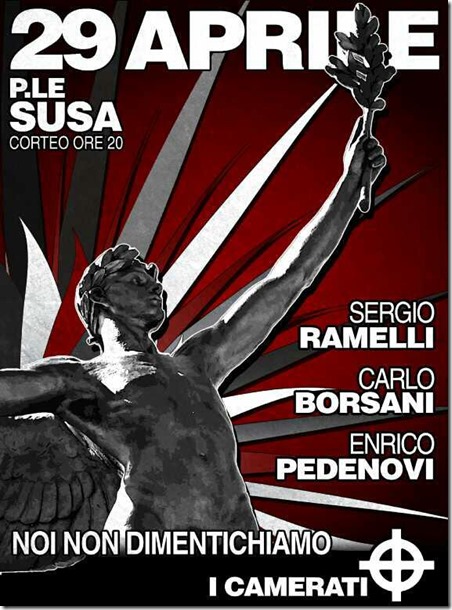

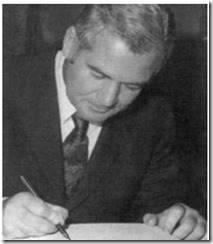
Nessun commento:
Posta un commento